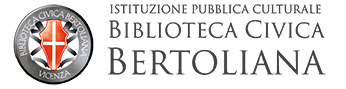Fiori Musicali
Cruda Sorte Mia
Musica a Napoli ai tempi di Gesualdo
Mercoledì 7 Maggio 2025 | ore 18.00 | Palazzo Cordellina

Cos'è
Cruda Sorte Mia
Musica a Napoli ai tempi di Gesualdo
Letture da Lettere agli amici di Pierpaolo Pasolini, a cura degli studenti del Liceo “Antonio Pigafetta” di Vicenza: Leonardo Bertuzzo, Andjela Dordevic, Viola Muraro, Caterina Timpretti, Emanuele Torregrossa
Referente del Liceo “Antonio Pigafetta”: prof.ssa Elena Pastorio
Formazione lettori: Martina Pittarello
Scelta dei testi: Oreste Palmiero
CARLO GESUALDO DA VENOSA “Tristis est anima mea”. Responsorio a 6 voci del Giovedì (1560-1613) Santo (1611)
GIOVANNI MARIA TRABACI Aria di Venere. Delizie di Posillipo (Napoli, 1620)
(1575-1647)
CARLO GESUALDO DA VENOSA “O vos omnes”. Responsorio a 6 voci per il Sabato Santo n. 5 (1611)
ADRIANO WILLAERT “Vecchie letrose” (Canzoni villanesche alla napolitana, 1545)
(1490 ca.-1562)
CARLO GESUALDO DA VENOSA “Moro, lasso”. Madrigale a 5 voci, Libro VI (1611)
GIOVANNI MARIA TRABACI Aria di tre sirene. Delizie di Posillipo (Napoli, 1620)
CARLO GESUALDO DA VENOSA “O vos omnes”. Mottetto a 5 voci (1603)
Valentina Fin, soprano
Giulia Gabrielli, soprano
Francisco Ricardo, contralto
Luigi Pinto, tenore
prof.ssa Rosita Ippolito, Teresina Croce, Patrizia Belluzzo,
Cosimo Rutigliano, Paolo Iseppi, Caterina Colelli, viole da gamba
Con il sostegno degli Amici della Bertoliana
Concerto in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana e Liceo Pigafetta
Passeggiando sul lungomare di Castel dell’Ovo, ai piedi della collina di Posillipo, si incontra una monumentale costruzione barocca che si staglia contro il mare: è la fontana del Sebeto, voluta nel 1635 dal Viceré di Napoli per omaggiare le acque di un fiume ormai scomparso, ma ancora vivo nella memoria della città. Scolpito nel marmo con le sembianze di un vecchio accigliato, il Sebeto è un fiume fantasma che da secoli scorre sotto terra e nell’immaginario napoletano.
Il suo corso tumultuoso, narra il mito, si placa nel punto in cui sfocia sulla spiaggia della futura Neapolis, abbracciando le spoglie della sirena Partenope, morta d’amore per l’inflessibile Odisseo. Il suo corpo, dissolvendosi, si fa terra: dalla testa ha origine Capodimonte, dai piedi un promontorio così dolce da meritare il nome di Pausilypon, “tregua dagli affanni”. È questa allegoria, tenera e oscura al contempo, a fare da cornice a Cruda sorte mia, programma per voci e consort di viole da gamba che ritrae l’universo musicale in cui visse e operò Carlo Gesualdo, Principe di Venosa.
Figura emblematica della polifonia rinascimentale, Gesualdo è noto tanto per l’audacia e la raffinatezza della scrittura quanto per le tragiche vicende biografiche. Nelle sue opere, il rigore contrappuntistico è spinto all’estremo dall’uso sapientemente elastico e tensivo di cromatismi e dissonanze. Questa tendenza è evidente nello struggente Moro, lasso dal Libro VI di Madrigali e nei Tenebrae Responsoria (entrambi pubblicati del 1611). Caratterizzati da uno stile emotivo e intimo, raro nella polifonia sacra coeva, questi ultimi sembrano riflettere una devozione sempre più tormentata e melanconica. Gesualdo li compose per l’Ufficio delle Tenebre della Settimana Santa, un rito antico che accompagnava i fedeli nell’attesa dell’oscurità calata sul mondo alla morte di Cristo. Trasfigurando il desiderio di redenzione nella dimensione sonora del sacro, le composizioni risuonavano con ogni probabilità nella penombra della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove il Principe partecipava alla sua liturgia privata con lo sguardo rivolto alla pala d’altare del Perdono che lo ritrae accanto allo zio, il cardinale Carlo Borromeo.
Se la musica di Gesualdo dipinge l’anima più cupa e passionale del vicereame, il Sebeto ne racconta il volto solare e magniloquente, che fa del mito uno strumento di celebrazione del potere. Il 1° marzo 1620 la corte vicereale diede una grande festa a ballo per celebrare la guarigione di Filippo III Re di Spagna. Il dettagliato resoconto si trova nella raccolta Delizie di Posilipo Boscarecce e Maritime, ove il cronista, con un abile espediente narrativo, si finge il Sebeto, che attraversa le bellezze arcadiche del Monte Posillipo, già emblema del Viceré. Le Delizie, oltre all’accurata descrizione delle scene di danza e teatro musicale, raccolgono il repertorio di canzonette presentate nei festeggiamenti. Tra queste, l’Aria delle Sirene e l’Aria di Venere, musicate dal maestro di cappella Giovanni Maria Trabaci, la cui scrittura melodica, morbida e fluente, prelude alla cantata italiana.
A completare questo chiaroscuro, alcune danze strumentali dello stesso Trabaci e dei fiamminghi Jean Macque e Giaches de Wert, insieme a una vivace villanella alla napoletana di Adrian Willaert, che – uscendo dalla raffinatezza di corte – trasporta l’ascoltatore tra i quartieri più popolari del Vicereame. Ne risulta un affresco musicale a più voci della Napoli seicentesca, sospesa tra fasto e inquietudine, luce e ombra.
Luisa Torresan
(Le note di sala sono state redatte nell’ambito
del corso di Strumenti e metodi della ricerca bibliografica,
tenuto dalla prof.ssa Maria Borghesi)
A chi è rivolto
Pubblico di ogni età
Luogo
Date e orari
Costi
GRATUITO
Ingresso gratuito
Contatti
Ulteriori informazioni
Presenti all'evento
Patrocinio
| Name | Link |
|---|---|
| Comune di Vicenza | https://www.comune.vicenza.it/ |
Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 30 Aprile 2025